Cibo E Cultura: La Storia Delle Patate
di Gianluigi Storto.
Come la gastronomia fece di un alimento per bestie un cibo per signori: la storia delle patate
Si dice spesso che la differenza fra nutrirsi è mangiare è culturale. Un libro interessantissimo, di cui consiglio la lettura a tutti gli appassionati di gastronomia, “La fame e l’abbondanza” di Massimo Montanari, dimostra con mille esempi come la cultura abbia influenzato le abitudini alimentari dell’uomo. L’esempio che volevo prendere dal libro di Montanari, per fare alla fine dell’articolo un timido link con la neonata Compagnia del Cibo Sincero, è quello dell’atteggiamento culturale degli europei nei confronti dei nuovi cibi venuti dalle Americhe dopo la scoperta di Colombo.
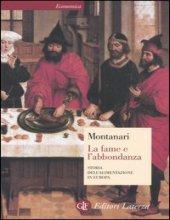 Scrive Montanari: “Dal momento in cui i nuovi cibi (come mais o patate, ndr)furono conosciuti dagli europei a quello in cui diventarono effettivamente importanti nel loro sistema alimentare passò un lasso di tempo enorme“. Di fatto furono necessari due-trecento anni perché gli europei utilizzassero come veri alimenti i cibi venuti dal Nuovo Mondo. Ci furono ovviamente alcune importanti eccezioni, ma il ritardo fu così grande che è corretto interrogarsi sulle sue motivazioni. E indagando su questo strano fenomeno si vede bene come il cibo non serve soltanto a sfamarsi ma a soddisfare un insieme di bisogni culturali (come sa – e sfrutta!- ogni buon gastronomo).
Scrive Montanari: “Dal momento in cui i nuovi cibi (come mais o patate, ndr)furono conosciuti dagli europei a quello in cui diventarono effettivamente importanti nel loro sistema alimentare passò un lasso di tempo enorme“. Di fatto furono necessari due-trecento anni perché gli europei utilizzassero come veri alimenti i cibi venuti dal Nuovo Mondo. Ci furono ovviamente alcune importanti eccezioni, ma il ritardo fu così grande che è corretto interrogarsi sulle sue motivazioni. E indagando su questo strano fenomeno si vede bene come il cibo non serve soltanto a sfamarsi ma a soddisfare un insieme di bisogni culturali (come sa – e sfrutta!- ogni buon gastronomo).
 I nuovi prodotti che venivano dalle Americhe erano estranei – e non poteva essere diversamente – alle abitudini europee medievali. E così non furono accettati come cibi ma, al più, come curiosità aliene o come foraggi da bestiame. La loro diffusione, che in seguito fu enorme e planetaria, fu in realtà dovuta a cause drammatiche che costrinsero l’umanità a rivedere le proprie basi culturali per non scomparire. I nuovi cibi americani entrarono in Europa due volte: la prima nel ‘500, appena dopo la loro scoperta, più che altro come curiosità esotiche; la seconda nel corso del ‘700, a causa delle tremende carestie di quel secolo. Fu allora che, per fame, gli uomini cambiarono le proprie abitudini alimentari. Solo successivamente i nuovi cibi entrarono a pieno titolo fra gli alimenti tradizionali dei popoli europei. Ma vediamo meglio cosa successe.
I nuovi prodotti che venivano dalle Americhe erano estranei – e non poteva essere diversamente – alle abitudini europee medievali. E così non furono accettati come cibi ma, al più, come curiosità aliene o come foraggi da bestiame. La loro diffusione, che in seguito fu enorme e planetaria, fu in realtà dovuta a cause drammatiche che costrinsero l’umanità a rivedere le proprie basi culturali per non scomparire. I nuovi cibi americani entrarono in Europa due volte: la prima nel ‘500, appena dopo la loro scoperta, più che altro come curiosità esotiche; la seconda nel corso del ‘700, a causa delle tremende carestie di quel secolo. Fu allora che, per fame, gli uomini cambiarono le proprie abitudini alimentari. Solo successivamente i nuovi cibi entrarono a pieno titolo fra gli alimenti tradizionali dei popoli europei. Ma vediamo meglio cosa successe.
 Nel corso del ‘500 la popolazione europea era cresciuta moltissimo e in alcuni casi, come in alcune regioni spagnole, era addirittura raddoppiata. Molti Paesi, che fino ad allora avevano esportato derrate alimentari, prima fra tutte i cereali, le dirottarono così sui propri mercati interni, facendo salire i prezzi nel resto del mondo. Le strutture produttive, assolutamente primitive e non meccanizzate, entrarono in crisi, con una serie di drammatiche conseguenze sul tenore di vita medio, già molto depresso, almeno rispetto ai nostri giorni. Come risposta alla crisi alimentare, si restrinsero i terreni da pascolo per destinarli all’agricoltura, si fecero opere di disboscamento e di bonifica di paludi, ma con risultati non sempre entusiasmanti e comunque insufficienti.
Nel corso del ‘500 la popolazione europea era cresciuta moltissimo e in alcuni casi, come in alcune regioni spagnole, era addirittura raddoppiata. Molti Paesi, che fino ad allora avevano esportato derrate alimentari, prima fra tutte i cereali, le dirottarono così sui propri mercati interni, facendo salire i prezzi nel resto del mondo. Le strutture produttive, assolutamente primitive e non meccanizzate, entrarono in crisi, con una serie di drammatiche conseguenze sul tenore di vita medio, già molto depresso, almeno rispetto ai nostri giorni. Come risposta alla crisi alimentare, si restrinsero i terreni da pascolo per destinarli all’agricoltura, si fecero opere di disboscamento e di bonifica di paludi, ma con risultati non sempre entusiasmanti e comunque insufficienti.
 In Lombardia nacquero le prime coltivazioni intensive di riso, un alimento considerato fino ad allora “esotico” (era stato importato dagli arabi dall’Oriente) che però ben si prestava alla coltivazione del settentrione d’Italia. Ma nonostante questi ed altri tentativi di rispondere all’aumento del numero delle bocche da sfamare, senza l’aiuto dei concimi chimici o delle moderne conoscenze agronomiche o dell’industrializzazione dei processi agricoli, ma soprattutto per laresistenza culturale ad accettare i nuovi cibi americani, ben presto comparvero le vecchie e temutissime carestie, che scatenarono guerre che a loro volta ne aggravarono il problema, in un circolo vizioso disastroso per le popolazioni europee. Alla fame si rispose con l’utilizzo dei nuovi prodotti: il riso, come abbiamo già visto, e il grano saraceno che fece diventare grigia la polenta che fino ad allora era stata gialla perché prodotta da miglio.
In Lombardia nacquero le prime coltivazioni intensive di riso, un alimento considerato fino ad allora “esotico” (era stato importato dagli arabi dall’Oriente) che però ben si prestava alla coltivazione del settentrione d’Italia. Ma nonostante questi ed altri tentativi di rispondere all’aumento del numero delle bocche da sfamare, senza l’aiuto dei concimi chimici o delle moderne conoscenze agronomiche o dell’industrializzazione dei processi agricoli, ma soprattutto per laresistenza culturale ad accettare i nuovi cibi americani, ben presto comparvero le vecchie e temutissime carestie, che scatenarono guerre che a loro volta ne aggravarono il problema, in un circolo vizioso disastroso per le popolazioni europee. Alla fame si rispose con l’utilizzo dei nuovi prodotti: il riso, come abbiamo già visto, e il grano saraceno che fece diventare grigia la polenta che fino ad allora era stata gialla perché prodotta da miglio.
 E poi il mais. Questo cereale, conosciuto da Colombo già nel suo primo viaggio in America, fu portato in Europa già nel 1493. Ma fu messo a coltura più per curiosità che per altro e quasi mai sostituì il grano nelle coltivazioni estese e rivolte al soddisfacimento di reali necessità alimentari. I nomi con cui il mais fu chiamato in Europa fanno capire che esso fu mentalmente assimilato ai più conosciuti miglio e sorgo: in Francia ancora adesso è millet (miglio), in molti dialetti italiani melega(sorgo), in Ungheria tengeribùza (miglio di mare), nei Balcani è fava, miglio, sorgo, grano, grano grosso. Poi ci furono denominazioni esotiche:grano rosso, grano turco, grano d’Egitto, grano arabo, eccetera. Ma appena il pericolo delle carestie passò a causa della diminuzione della popolazione e di migliori raccolti di grano, ecco che si tornò ad ignorarlo: il mais non fu mai utilizzato nella cucina “alta” e i contadini, da parte loro, continuavano a considerarlo un alimento da bestie più che da uomini.
E poi il mais. Questo cereale, conosciuto da Colombo già nel suo primo viaggio in America, fu portato in Europa già nel 1493. Ma fu messo a coltura più per curiosità che per altro e quasi mai sostituì il grano nelle coltivazioni estese e rivolte al soddisfacimento di reali necessità alimentari. I nomi con cui il mais fu chiamato in Europa fanno capire che esso fu mentalmente assimilato ai più conosciuti miglio e sorgo: in Francia ancora adesso è millet (miglio), in molti dialetti italiani melega(sorgo), in Ungheria tengeribùza (miglio di mare), nei Balcani è fava, miglio, sorgo, grano, grano grosso. Poi ci furono denominazioni esotiche:grano rosso, grano turco, grano d’Egitto, grano arabo, eccetera. Ma appena il pericolo delle carestie passò a causa della diminuzione della popolazione e di migliori raccolti di grano, ecco che si tornò ad ignorarlo: il mais non fu mai utilizzato nella cucina “alta” e i contadini, da parte loro, continuavano a considerarlo un alimento da bestie più che da uomini.
 Insomma i nuovi cibi si affacciarono timidamente alle mense ma appena fu possibile gli uomini ne fecero nuovamente a meno, tornando alle loro abitudini alimentari precedenti e destinando questi nuovi alimenti alle bestie o al rango di curiosità gastronomiche. Non erano stati accettati dalla cultura del tempo. Fu nel ‘700, il secolo della fame, che le cose cambiarono drasticamente. La popolazione europea, che nel ‘300 era di circa 90 milioni di individui, nel ‘700 era di circa 125 milioni. Ma fu nel secolo dei lumi che in pochi anni, per le migliorate condizioni di vita, questo numero crebbe in maniera spaventosa: 145 milioni a metà ‘700 e195 sul finire del secolo. I sistemi produttivi, tuttavia, erano rimasti praticamente quelli del Medioevo. Le carestie si abbatterono senza pietà sugli strati sociali più deboli. Quella famosissima del 1709-1710 colpì tutto il continente, mietendo milioni di vittime dalla Spagna, alla Francia, all’Inghilterra, all’Italia, alla Germania, ai Paesi dell’est. La carestia del 1739-41 colpì invece soltanto Francia e Germania, quella del 1741-43 l’Inghilterra, quella del 1764-67 i Paesi meridionali come Italia e Spagna, quella del 1771-74 i Paesi del nord Europa.
Insomma i nuovi cibi si affacciarono timidamente alle mense ma appena fu possibile gli uomini ne fecero nuovamente a meno, tornando alle loro abitudini alimentari precedenti e destinando questi nuovi alimenti alle bestie o al rango di curiosità gastronomiche. Non erano stati accettati dalla cultura del tempo. Fu nel ‘700, il secolo della fame, che le cose cambiarono drasticamente. La popolazione europea, che nel ‘300 era di circa 90 milioni di individui, nel ‘700 era di circa 125 milioni. Ma fu nel secolo dei lumi che in pochi anni, per le migliorate condizioni di vita, questo numero crebbe in maniera spaventosa: 145 milioni a metà ‘700 e195 sul finire del secolo. I sistemi produttivi, tuttavia, erano rimasti praticamente quelli del Medioevo. Le carestie si abbatterono senza pietà sugli strati sociali più deboli. Quella famosissima del 1709-1710 colpì tutto il continente, mietendo milioni di vittime dalla Spagna, alla Francia, all’Inghilterra, all’Italia, alla Germania, ai Paesi dell’est. La carestia del 1739-41 colpì invece soltanto Francia e Germania, quella del 1741-43 l’Inghilterra, quella del 1764-67 i Paesi meridionali come Italia e Spagna, quella del 1771-74 i Paesi del nord Europa.
 Il ‘700 fu un secolo difficilissimo, pari forse solo all’XI secolo, quello in cui si era temuta la fine del mondo e non è forse un caso che verso la sua fine scoppiò la Rivoluzione Francese, che tanta importanza avrebbe avuto – e ancora ha – sulla storia dei popoli. All’aumento della richiesta di cibo si rispose come sempre aumentando le superfici coltivate, prosciugando acquitrini e paludi, mettendo a coltura boschi e terreni precedentemente inutilizzati. In questo secolo si cominciò ad applicare ilrovescio dei terreni, ovvero la loro rotazione periodica per accrescere le rese agricole e si mescolarono, per così dire, le attività agrarie con quellezootecniche, prima tenute separate, per permettere una migliore concimazione naturale del suolo. Ciò portò a un certo aumento delle rese ma ancora insufficiente per sfamare tutti.
Il ‘700 fu un secolo difficilissimo, pari forse solo all’XI secolo, quello in cui si era temuta la fine del mondo e non è forse un caso che verso la sua fine scoppiò la Rivoluzione Francese, che tanta importanza avrebbe avuto – e ancora ha – sulla storia dei popoli. All’aumento della richiesta di cibo si rispose come sempre aumentando le superfici coltivate, prosciugando acquitrini e paludi, mettendo a coltura boschi e terreni precedentemente inutilizzati. In questo secolo si cominciò ad applicare ilrovescio dei terreni, ovvero la loro rotazione periodica per accrescere le rese agricole e si mescolarono, per così dire, le attività agrarie con quellezootecniche, prima tenute separate, per permettere una migliore concimazione naturale del suolo. Ciò portò a un certo aumento delle rese ma ancora insufficiente per sfamare tutti.
 Fu allora che venne riscoperto ancora una volta il riso, che abbandonò per sempre la sua natura di cibo ricercato ed esotico per acquistarne una di cibo dei poveri. Viene riscoperto anche il grano saraceno, il mais e finalmente si inizia ad utilizzare la patata, fino ad allora di fatto ignorata, anzi considerata un non cibo. Eppure le patate, a parità di superficie coltivata, riescono a sfamare il triplo della popolazione. Le Accademie scientifiche si ingegnarono per trovare il modo di sfamare le popolazioni e un concorso del 1772 venne vinto da Parmentier, che poi avrebbe legato il suo nome a un consommé di patate, proprio con un trattato sulla coltivazione del nuovo tubero americano. Questi nuovi alimenti furono interpretati culturalmente dalle popolazioni in modo assai diverso da come avevano fatto i nativi americani: gli europei lo assimilarono alle loro precedenti abitudini alimentari, integrandolo cioè nella cultura europea e non semplicemente adottandolo come cibo nuovo, degno di una gastronomia innovativa e diversa.
Fu allora che venne riscoperto ancora una volta il riso, che abbandonò per sempre la sua natura di cibo ricercato ed esotico per acquistarne una di cibo dei poveri. Viene riscoperto anche il grano saraceno, il mais e finalmente si inizia ad utilizzare la patata, fino ad allora di fatto ignorata, anzi considerata un non cibo. Eppure le patate, a parità di superficie coltivata, riescono a sfamare il triplo della popolazione. Le Accademie scientifiche si ingegnarono per trovare il modo di sfamare le popolazioni e un concorso del 1772 venne vinto da Parmentier, che poi avrebbe legato il suo nome a un consommé di patate, proprio con un trattato sulla coltivazione del nuovo tubero americano. Questi nuovi alimenti furono interpretati culturalmente dalle popolazioni in modo assai diverso da come avevano fatto i nativi americani: gli europei lo assimilarono alle loro precedenti abitudini alimentari, integrandolo cioè nella cultura europea e non semplicemente adottandolo come cibo nuovo, degno di una gastronomia innovativa e diversa.
 Questo tentativo, almeno fino all’800, riuscì con il grano saraceno e con il mais, ma fallì con la patata. I contadini pensarono per molto tempo di poterne fare un ingrediente base del pane (ancora oggi in molte campagne resiste un uso analogo), che era l’alimento popolare per eccellenza, ma gli insuccessi legati a tale impiego la relegarono a cibo per maiali. La patata si diffuse soltanto come cibo di carestia, dietro la spinta della fame e soprattutto grazie al fatto che, crescendo sotto terra, era parzialmente al riparo dalle devastazioni delle guerre. Già nella prima parte del ‘700, varie autorità europee cercarono di sollecitare la coltivazione del “tartufo bianco”, come era chiamata la patata, ma incontrarono difficoltà e resistenze da parte delle popolazioni, specialmente le più povere, cui i messaggi erano rivolti. Federico Guglielmo re di Prussia e suo figlio Federico il Grande presero provvedimenti per diffonderne l’uso ma furono soprattutto la guerra dei sette anni e la carestia del 1770-72 a introdurla in Germania, dove successivamente sarebbe diventata un alimento diffusissimo. Ma all’inizio fu cibo di carestia o comunque per poveri, che serviva soprattutto per riempire la pancia ma non certo per alimentare le tavole dei ceti ricchi e aristocratici.
Questo tentativo, almeno fino all’800, riuscì con il grano saraceno e con il mais, ma fallì con la patata. I contadini pensarono per molto tempo di poterne fare un ingrediente base del pane (ancora oggi in molte campagne resiste un uso analogo), che era l’alimento popolare per eccellenza, ma gli insuccessi legati a tale impiego la relegarono a cibo per maiali. La patata si diffuse soltanto come cibo di carestia, dietro la spinta della fame e soprattutto grazie al fatto che, crescendo sotto terra, era parzialmente al riparo dalle devastazioni delle guerre. Già nella prima parte del ‘700, varie autorità europee cercarono di sollecitare la coltivazione del “tartufo bianco”, come era chiamata la patata, ma incontrarono difficoltà e resistenze da parte delle popolazioni, specialmente le più povere, cui i messaggi erano rivolti. Federico Guglielmo re di Prussia e suo figlio Federico il Grande presero provvedimenti per diffonderne l’uso ma furono soprattutto la guerra dei sette anni e la carestia del 1770-72 a introdurla in Germania, dove successivamente sarebbe diventata un alimento diffusissimo. Ma all’inizio fu cibo di carestia o comunque per poveri, che serviva soprattutto per riempire la pancia ma non certo per alimentare le tavole dei ceti ricchi e aristocratici.
 I contadini reagirono a questa divaricazione social-alimentare intuendo, dietro lo sforzo di diffusione del nuovo cibo un altro modo per impoverire ulteriormente la loro alimentazione già insufficiente, riservando ai signori i cibi di migliore qualità. Tra l’altro le patate di allora, che non avevano ancora beneficiato degli incroci migliorativi di cui godiamo ai giorni nostri, erano diverse dalle attuali: la polpa era acida e spesso acquosa, il contenuto della tossina tipica della patata – la solanina – era spesso molto alto cosicché spesso era pericolosa se assunta in grandi quantitativi. Per molto tempo i signori ne imposero la coltivazione nei contratti agrari, obbligando i conduttori a riservare parte del fondo alla coltivazione dei tuberi. Fu solamente nell’800 che la gastronomia fece della patata un alimento e non soltanto un cibo da carestia, cosa che invece non accadde mai per il mais, che restò sempre un alimento povero (guarda caso ancor oggi si cerca di farne materia prima per produrre alcool per carburanti piuttosto che un alimento per le masse affamate).
I contadini reagirono a questa divaricazione social-alimentare intuendo, dietro lo sforzo di diffusione del nuovo cibo un altro modo per impoverire ulteriormente la loro alimentazione già insufficiente, riservando ai signori i cibi di migliore qualità. Tra l’altro le patate di allora, che non avevano ancora beneficiato degli incroci migliorativi di cui godiamo ai giorni nostri, erano diverse dalle attuali: la polpa era acida e spesso acquosa, il contenuto della tossina tipica della patata – la solanina – era spesso molto alto cosicché spesso era pericolosa se assunta in grandi quantitativi. Per molto tempo i signori ne imposero la coltivazione nei contratti agrari, obbligando i conduttori a riservare parte del fondo alla coltivazione dei tuberi. Fu solamente nell’800 che la gastronomia fece della patata un alimento e non soltanto un cibo da carestia, cosa che invece non accadde mai per il mais, che restò sempre un alimento povero (guarda caso ancor oggi si cerca di farne materia prima per produrre alcool per carburanti piuttosto che un alimento per le masse affamate).
 Creme di patate (la famosa Parmentier), patate al forno, patate per fare specie di maccheroni (gli gnocchi), patate fritte, patate bollite e impastate con uova e spezie per farne secondi gustosi e molto appetibili e tantissime altre ricette ne fecero uno degli alimenti più gustosi della cucina “alta”. E dalla cucina “alta” a quella popolare, per spirito diimitazione sociale, il passo fu assai breve e ben presto la patata divenne un alimento diffusissimo, anche troppo. Non bisogna infatti dimenticare i danni causati dal monofagismo, ovvero da situazioni in cui una intera popolazione dipende, da un punto di vista alimentare, da un solo tipo di coltura agricola. Basti ricordare cosa successe in Irlanda nel biennio 1845-46: una tragedia di dimensioni nazionali. Due raccolti di patate andati a male annientarono di fatto una società contadina che aveva basato soltanto su quella coltivazione le proprie speranze di autosufficienza alimentare. La carestia irlandese fu la principale causa dello spopolamento dell’isola e della contemporanea massiccia migrazione negli Stati Uniti. Morirono circa un terzo di irlandesi, in alcune zone anche di più e il numero di abitanti, che nel 1841 ammontava a circa 8 milioni di individui, agli inizi del ‘900 non era ancora riuscita a superare i 5! Da allora i campi irlandesi, prima coltivati a patate e poi abbandonati, furono destinati alla produzione di pascoli per produrre carne da inviare al più ricco mercato inglese, rovinando ancor più l’economia dell’isola verde.
Creme di patate (la famosa Parmentier), patate al forno, patate per fare specie di maccheroni (gli gnocchi), patate fritte, patate bollite e impastate con uova e spezie per farne secondi gustosi e molto appetibili e tantissime altre ricette ne fecero uno degli alimenti più gustosi della cucina “alta”. E dalla cucina “alta” a quella popolare, per spirito diimitazione sociale, il passo fu assai breve e ben presto la patata divenne un alimento diffusissimo, anche troppo. Non bisogna infatti dimenticare i danni causati dal monofagismo, ovvero da situazioni in cui una intera popolazione dipende, da un punto di vista alimentare, da un solo tipo di coltura agricola. Basti ricordare cosa successe in Irlanda nel biennio 1845-46: una tragedia di dimensioni nazionali. Due raccolti di patate andati a male annientarono di fatto una società contadina che aveva basato soltanto su quella coltivazione le proprie speranze di autosufficienza alimentare. La carestia irlandese fu la principale causa dello spopolamento dell’isola e della contemporanea massiccia migrazione negli Stati Uniti. Morirono circa un terzo di irlandesi, in alcune zone anche di più e il numero di abitanti, che nel 1841 ammontava a circa 8 milioni di individui, agli inizi del ‘900 non era ancora riuscita a superare i 5! Da allora i campi irlandesi, prima coltivati a patate e poi abbandonati, furono destinati alla produzione di pascoli per produrre carne da inviare al più ricco mercato inglese, rovinando ancor più l’economia dell’isola verde.
 Ma torniamo al successo delle patate all’inizio dell’800. Già i libri dei primi anni del secolo portarono le patate sulle tavole di ricchi borghesi e dell’aristocrazia. Insomma la patata era divenuto un alimento culturalmente accettato ed era ormai sulle tavole di tutti. In conclusione possiamo dire che non è la disponibilità o le proprietà nutrizionali o la facilità di coltivazione e neanche il prezzo a fare di un alimento un cibo ma soltanto la sua approvazione culturale e sociale, ovvero il fatto che esso sia riconosciuto all’interno di un sistema di valori e di usi consolidati. Sono considerazioni che, trovandoci proprio in questi anni davanti a una crescita tumultuosa della popolazione mondiale e a un forte aumento del prezzo delle materie prime alimentari, devono far riflettere: non basta che qualcuno scopra che qualcosa sia nutriente perché esso diventi un alimento, è necessario che la società, nel suo insieme faccia di quel cibo un vero e proprio alimento accettato culturalmente, che esso “entri” nel nostro universo di valori come un “bisogno”.
Ma torniamo al successo delle patate all’inizio dell’800. Già i libri dei primi anni del secolo portarono le patate sulle tavole di ricchi borghesi e dell’aristocrazia. Insomma la patata era divenuto un alimento culturalmente accettato ed era ormai sulle tavole di tutti. In conclusione possiamo dire che non è la disponibilità o le proprietà nutrizionali o la facilità di coltivazione e neanche il prezzo a fare di un alimento un cibo ma soltanto la sua approvazione culturale e sociale, ovvero il fatto che esso sia riconosciuto all’interno di un sistema di valori e di usi consolidati. Sono considerazioni che, trovandoci proprio in questi anni davanti a una crescita tumultuosa della popolazione mondiale e a un forte aumento del prezzo delle materie prime alimentari, devono far riflettere: non basta che qualcuno scopra che qualcosa sia nutriente perché esso diventi un alimento, è necessario che la società, nel suo insieme faccia di quel cibo un vero e proprio alimento accettato culturalmente, che esso “entri” nel nostro universo di valori come un “bisogno”.
 In questo passaggio di significato, la gastronomia può dare un contributo fondamentale, come fece nel ‘700 con le patate. Qui lancio il mio sasso nello stagno: queste considerazioni possono alimentare ulteriori riflessioni all’interno della neonata Compagnia del Cibo Sincero? In fondo far diventare un cibo fino ad allora poco considerato, anzi ritenuto più foraggio da bestiame che cibo per uomini, ma in realtà genuino e salutare, un alimento per mense aristocratiche ma anche alla portata di tutte le tasche, non fu un successo gastronomico di cui la Compagnia del Cibo Sincero, se solo fosse esistita, sarebbe andata fiera?
In questo passaggio di significato, la gastronomia può dare un contributo fondamentale, come fece nel ‘700 con le patate. Qui lancio il mio sasso nello stagno: queste considerazioni possono alimentare ulteriori riflessioni all’interno della neonata Compagnia del Cibo Sincero? In fondo far diventare un cibo fino ad allora poco considerato, anzi ritenuto più foraggio da bestiame che cibo per uomini, ma in realtà genuino e salutare, un alimento per mense aristocratiche ma anche alla portata di tutte le tasche, non fu un successo gastronomico di cui la Compagnia del Cibo Sincero, se solo fosse esistita, sarebbe andata fiera?
Gianluigi Storto



