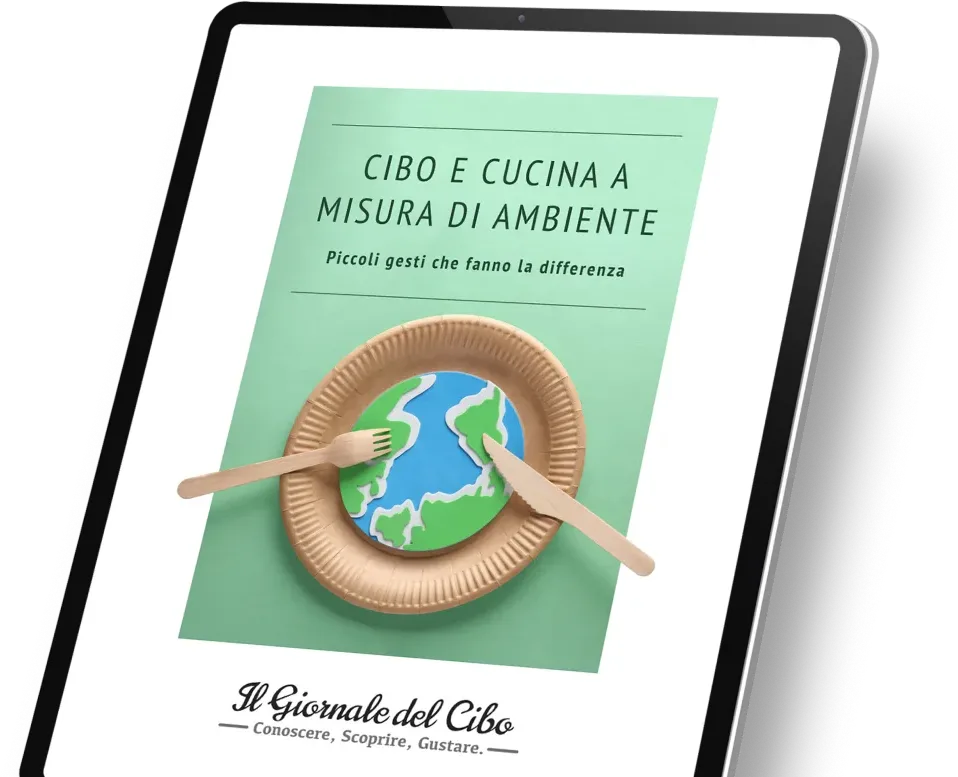Tra le colline della provincia di Enna, nel cuore della Sicilia, il Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei è molto più di un progetto agricolo. È un luogo dove il passato e il futuro dialogano attraverso la terra, dove la sostenibilità si intreccia con un forte desiderio di comunità. Come racconta Piero Consentino, agricoltore e vicepresidente del Biodistretto, “Per noi lavorare in campagna significa rigenerare un contatto perduto e una rete di persone che vivono questo territorio. La nostra visione è questa: avere l’opportunità di fare qualcosa credendoci davvero e di farlo insieme, come una collettività”.
Di questo e di molto altro ne abbiamo parlato appunto con Piero Consentino, per farci raccontare cos’è un biodistretto e con quali esigenze è nato questo progetto.
Un territorio a vocazione cerealicola: i grani antichi siciliani

Prima di parlare del Biodistretto e della sua nascita, dobbiamo fare un passo indietro per inquadrare l’area in cui ci stiamo muovendo. Ci troviamo nella verdissima e suggestiva zona dei Monti Erei, che caratterizzano orograficamente l’intera provincia di Enna. Qui, Piero Consentino ha ereditato dal nonno un’azienda agricola, a vocazione cerealicola, come la maggior parte delle aziende nel territorio dell’ennese. “Sono un agricoltore custode” – racconta, “da quando ho iniziato a gestire l’azienda ho scelto fin da subito di dedicarmi alla coltivazione dei grani antichi siciliani. E con gli anni sono diventato custode riconosciuto di una varietà, il Margherito, che a livello genetico e fenologico è pressoché identica al Senatore Cappelli: quando quest’ultimo è stato costituito, una parte della sperimentazione è stata fatta in Sicilia venendo appunto chiamato Margherito, dal nome della contrada dove è stato introdotto per la prima volta, nel territorio di Ramacca, nel catanese”. Viene anche chiamato Bidì, “e questo la dice lunga sull’origine del grano che in realtà proviene dalla Tunisia, perché è la storpiatura dialettale”: questa varietà deriva infatti da una popolazione nord africana denominata “Mahamuodi”, selezionata inizialmente dal genetista Nazareno Strampelli nel 1915 e oggi inserita nella lista delle varietà da conservazione.
Come spiega l’intervistato, inizialmente lavorare con i grani antichi è stato molto complesso: “In un’ottica agroecologica, è certamente vero che i grani antichi sono più resilienti e richiedono meno nutrienti, dall’altra parte, però, non è facile commercializzarli. È un mercato che resta una nicchia, sicuramente interessante in quanto indipendente dalla grande distribuzione, ma comunque non è semplice. Da questo punto di vista, il soccorso è arrivato da una cooperativa, Valdibella, di cui ormai faccio parte da alcuni anni. Valdibella ha sede a Camporeale (Palermo) ma raccoglie produttori nell’intero territorio regionale, principalmente di vino, mandorle, grano, e nasce da una visione etica più che commerciale”. Non a caso, da alcuni anni la cooperativa ha avviato un percorso di formazione di agroecologia, aperta a persone interne ma anche esterne.
Le radici del progetto del Biodistretto

Il Biodistretto è nato quindi dalla necessità di rispondere alle sfide agricole e sociali di oggi, partendo da una rete di piccoli produttori che condividevano una visione comune. “Valdibella ci ha stimolati a creare il Biodistretto. Lavoravamo già insieme con un approccio agroecologico, quindi abbiamo deciso di formalizzare questa rete”.
Il concetto di agroecologia va oltre il biologico: è una scienza, un complesso di pratiche e un movimento sociale. “Abbiamo deciso fin da subito di creare un biodistretto sì, ma che fosse agroecologico. L’agroecologia comporta tante scelte in campo, dal punto di vista agronomico ma anche da quello sociale: ha una visione complessiva del territorio e punta alla costruzione di vere e proprie comunità rurali” spiega Consentino. L’agroecologia si lega anche alla permacultura, un approccio integrato alla progettazione che punta a creare ambienti sostenibili, equilibrati e belli da vivere. Si basa sull’osservazione della natura e sull’applicazione di principi ecologici per ripristinare l’equilibrio dei sistemi che sostengono la vita: l’obiettivo è progettare ecosistemi produttivi che siano diversificati, stabili e flessibili, proprio come quelli naturali, promuovendo una relazione tra uomo e ambiente.
“Negli ultimi due anni ci siamo resi conto di quanto questa sperimentazione sia necessaria: ad oggi, il sistema agricolo e culturale da cui veniamo e che comunque portiamo avanti non è più adatto a rispondere agli stress climatici che ci sono stati e a cui andremo sempre più incontro”.
Una forma di governance territoriale che fa bene a tutti, ambiente e persone

Il Biodistretto è una forma innovativa di governance territoriale, in cui cittadini, istituzioni, agricoltori e altri protagonisti della filiera agricola collaborano per gestire il territorio in modo sostenibile, ispirandosi ai principi dell’agricoltura biologica e andando oltre, come abbiamo appena accennato. Come spiega Consentino, uno degli aspetti più interessanti è che si tratta di una formula sempre aperta: a differenza di un’associazione, se si ricade nell’area del biodistretto si ha diritto a farne parte. “Chiaramente riconoscendosi nelle regole e nei valori che il biodistretto si è dato”, specifica il vicepresidente.
Quello dei Monti Erei esiste da un anno, e tra i progetti in corso spicca la sperimentazione del Keyline Design: “Si tratta di un sistema di fossati lungo il campo che raccolgono l’acqua, rallentandone il deflusso e favorendo l’infiltrazione nel suolo. Questo approccio migliora la fertilità del terreno e mitiga i danni delle piogge estreme”. Di Keyline design si parla già dagli anni ‘80, ma in Italia non è diffuso, benché meno in Sicilia, come spiega Consentino. Questo approccio sfrutta la naturale conformazione del terreno per garantire una gestione efficace e sostenibile delle risorse idriche, divenute così preziose in un territorio come quello siciliano.
Non solo: il biodistretto ha anche avviato iniziative per rigenerare spazi urbani, come un giardino trasformato in centro educativo ambientale a Enna, all’interno del progetto “Leggere gli alberi, piantare una foresta” – XIV Festival del libro e della lettura. Hanno preso in gestione un terreno adiacente alle piscine comunali di Pergusa, effettuando una piantumazione, con la speranza che nel corso degli anni possa nascere e crescere un piccolo bosco. Consentino sottolinea l’importanza della collaborazione: “Stiamo valutando la creazione di un laboratorio di trasformazione collettivo per rispondere alle esigenze delle aziende agricole del territorio”.
Le sfide del cambiamento, tra resistenze culturali, siccità ed eventi estremi
Quali sono le sfide di un progetto come questo? L’abbiamo chiesto a Consentino, che ha risposto: “In realtà, abbiamo trovato molto interesse da parte della comunità nei confronti di ciò che stiamo facendo. Tuttavia, una difficoltà che accomuna noi e gli altri biodistretti che stanno nascendo in Sicilia riguarda il riconoscimento da parte della Regione. Perché la Sicilia non ha ancora una legge per quanto riguarda queste forme di governance, come ad esempio il Lazio, la Toscana o la Liguria”.
Per il resto, Consentino ha registrato una resistenza culturale rivolta più che altro verso il biologico: “È diffusa, ma spesso fragile. Molte aziende scelgono il biologico solo per convenienza economica, ma chi non è davvero convinto non dura a lungo. Alla prima difficoltà, nell’agricoltura convenzionale, si tende a usare subito l’arma disponibile per risolvere il problema. Il biologico e l’agroecologia, invece, adottano una prospettiva diversa, basata su un’altra dimensione temporale. È come scegliere il disarmo rispetto all’agricoltura tradizionale che conosciamo: un approccio trasformativo che, inevitabilmente, incontra sempre una certa resistenza”.
“I cambiamenti climatici sono irreversibili, quindi anche le conseguenze sono irreversibili”

Delle conseguenze dei cambiamenti climatici sull’agricoltura ne abbiamo parlato ampiamente in questi anni, e di fatto rappresentano la sfida principale e quella più pressante, come conferma l’intervistato.
“Come detto, buona parte del territorio è a vocazione cerealicola e si tratta di colture estensive, a basso reddito ma anche a basso input. Qui in Sicilia solo pochissime aziende producono grano con sistemi di irrigazione, sia per una questione pedologica, sia per una economica dato che le colture qui prodotte non lo giustificano a livello di investimento, sia perché manca la risorsa primaria: l’acqua. Buona parte del territorio non è servita, a volte nemmeno per uso civile, figurarsi a uso agricolo”, denuncia l’intervistato. Si tratta quindi di un’agricoltura che dipende dalle piogge meteoriche, che però negli ultimi anni non sono arrivate con regolarità: “I due anni precedenti sono stati devastanti. Nel 2024 abbiamo raggiunto il punto estremo: si sono svuotate le dighe, è iniziato il razionamento dell’acqua nei paesi e in agricoltura ne abbiamo risentito tantissimo. L’anno scorso ho perso il 100% della produzione: non ho raccolto quasi nulla di quello che ho piantato, e come me tanti altri. Non c’era né grano antico né biologico né convenzionale che tenesse”.
Quest’anno, racconta, l’annata sembra buona grazie alle piogge che sono tornate regolarmente, ma è evidente che qualcosa è cambiato. “I cambiamenti climatici sono un processo irreversibile, quindi anche le conseguenze sono irreversibili. Al di là dei buoni propositi, ci sono zone che con ogni probabilità, prima o poi, cambieranno destinazione d’uso, in cui l’agricoltura non sarà più praticabile. Noi stiamo cercando di adottare tecniche conservative per trattenere l’umidità nel suolo e mitigare i danni durante le piogge estreme, ma serve una visione a lungo termine. È importante capire infatti che non esiste una soluzione facile né tanto meno immediata: noi condividiamo una visione più olistica, in cui l’obiettivo è quello di ricreare il più velocemente possibile delle condizioni di stabilità e di biodiversità che si sono persi nel corso di secoli di sfruttamento del suolo. Se poi questo sistema sarà efficace contro i cambiamenti climatici non posso saperlo con certezza, ma se non è efficace questo ancora meno lo possono essere sistemi e pratiche più invasivi. Certamente si farà il possibile per salvare e difendere l’agricoltura convenzionale, ma a quale prezzo in termini ambientali e sociali?”
L’agricoltura come occasione per ricostruire le comunità
Il biodistretto offre quindi opportunità sia per l’ambiente che per le persone, soprattutto le nuove generazioni. Spesso l’agricoltura è percepita come un settore faticoso e poco remunerativo, specialmente per i giovani, ma per chi sceglie di intraprendere questa strada può diventare un’opportunità di rinascita personale e comunitaria. “Viviamo in una fase storica in cui stiamo sperimentando una precarietà profonda dal punto di vista economico e sociale, precarietà che ritroviamo anche in ambito rurale. Il punto è che la scelta di fare questo mestiere nasce da una scelta di vita, anche da un desiderio di indipendenza. Lavorare in campagna significa anche vivere in campagna, e per me è una parte essenziale della scelta. Dopodiché l’opportunità secondo me va un po’ generata, soprattutto se si è un piccolo produttore, perché il sistema non è fatto per loro. Cooperare in un biodistretto ci dà la forza di portare avanti un’agricoltura sostenibile che sarebbe difficile da gestire da soli”. Consentino sottolinea il valore delle relazioni: “Lavorare insieme significa anche ricostruire comunità. Una volta, le campagne erano vive perché popolate; oggi, rigenerare il suolo significa anche rigenerare le relazioni umane”.
Il Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei dimostra che l’agricoltura non è solo una sfida da affrontare ma anche una promessa da mantenere: quella di un futuro più sostenibile, fatto di comunità, rispetto per la terra e innovazione condivisa.